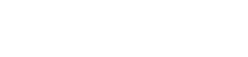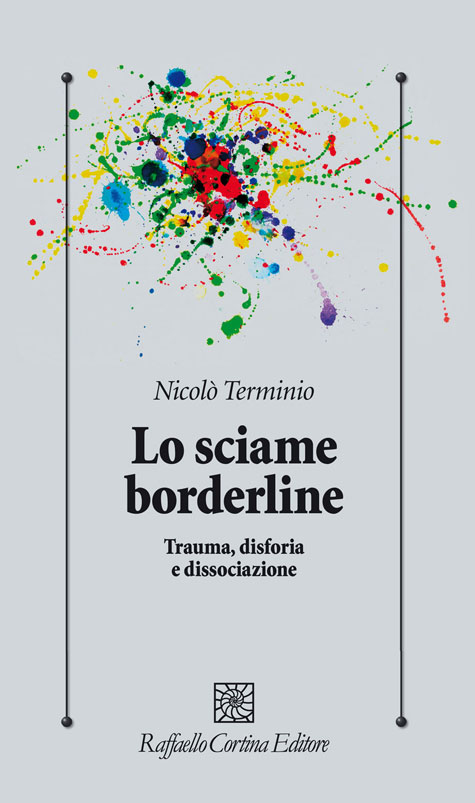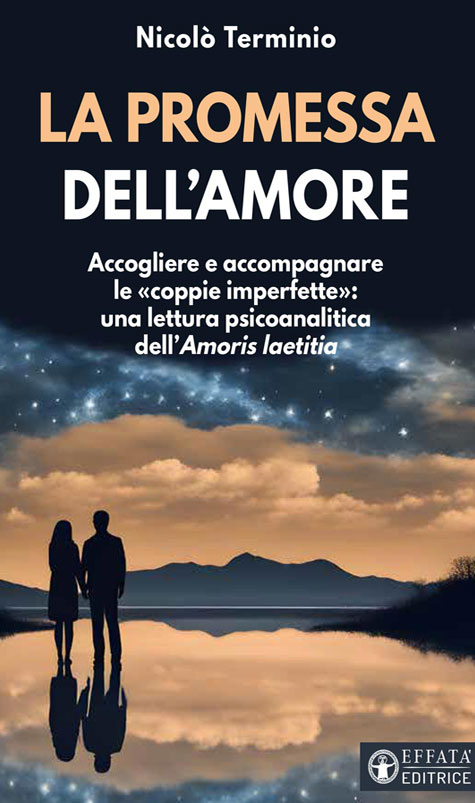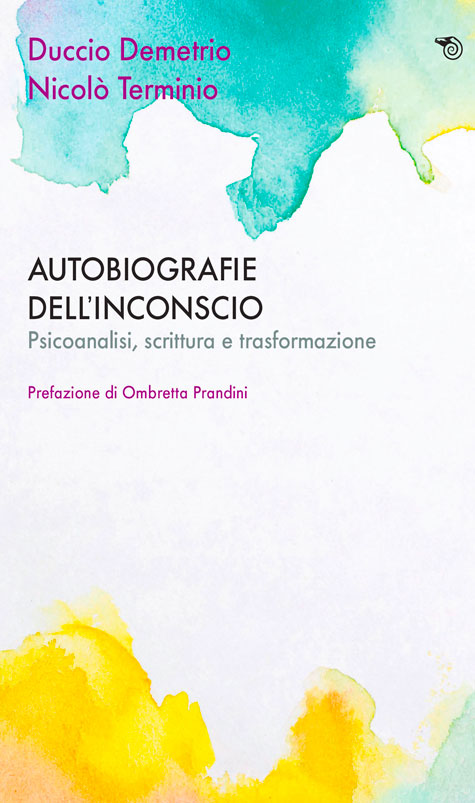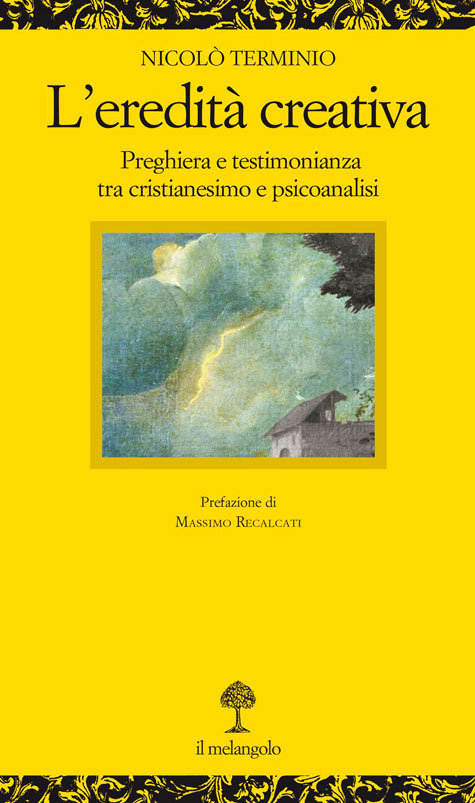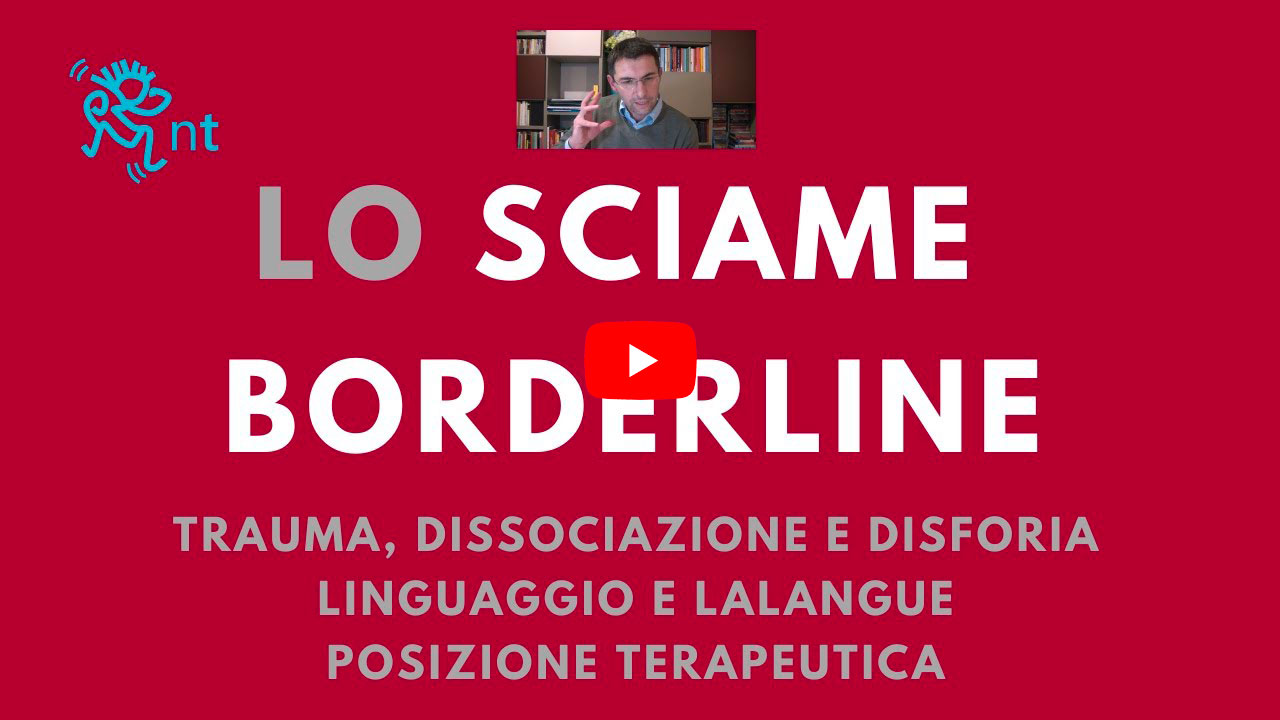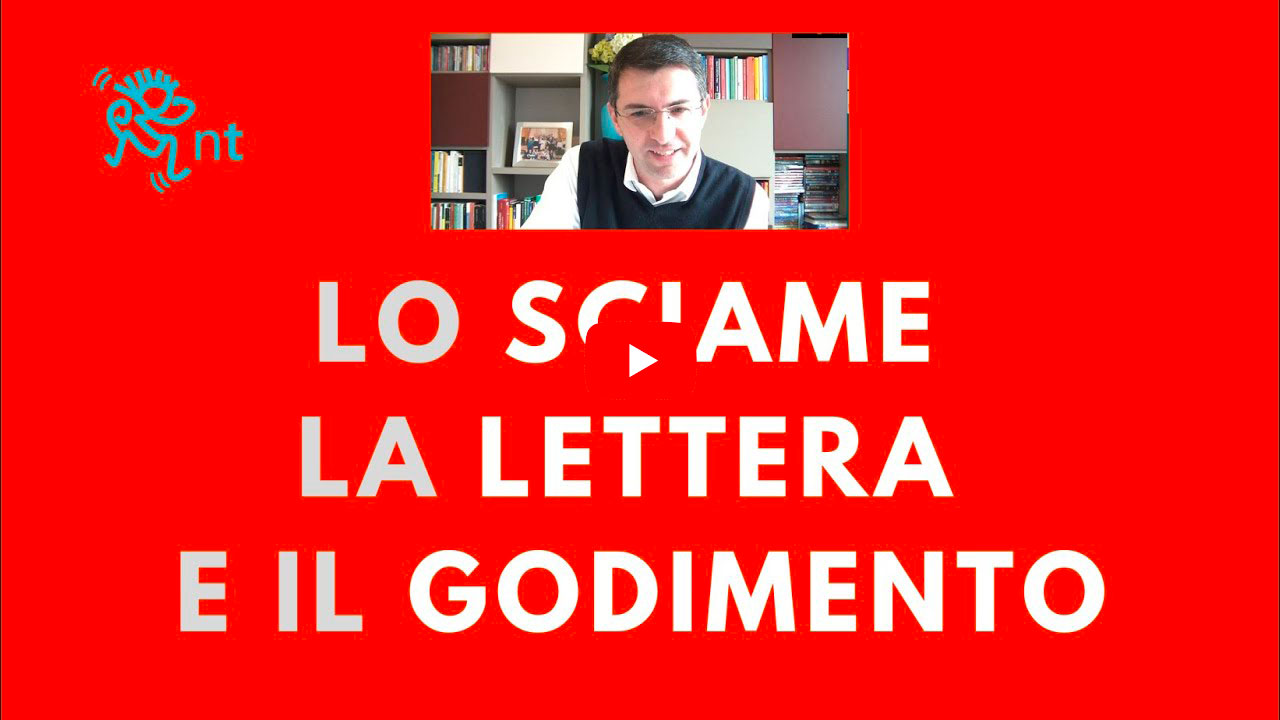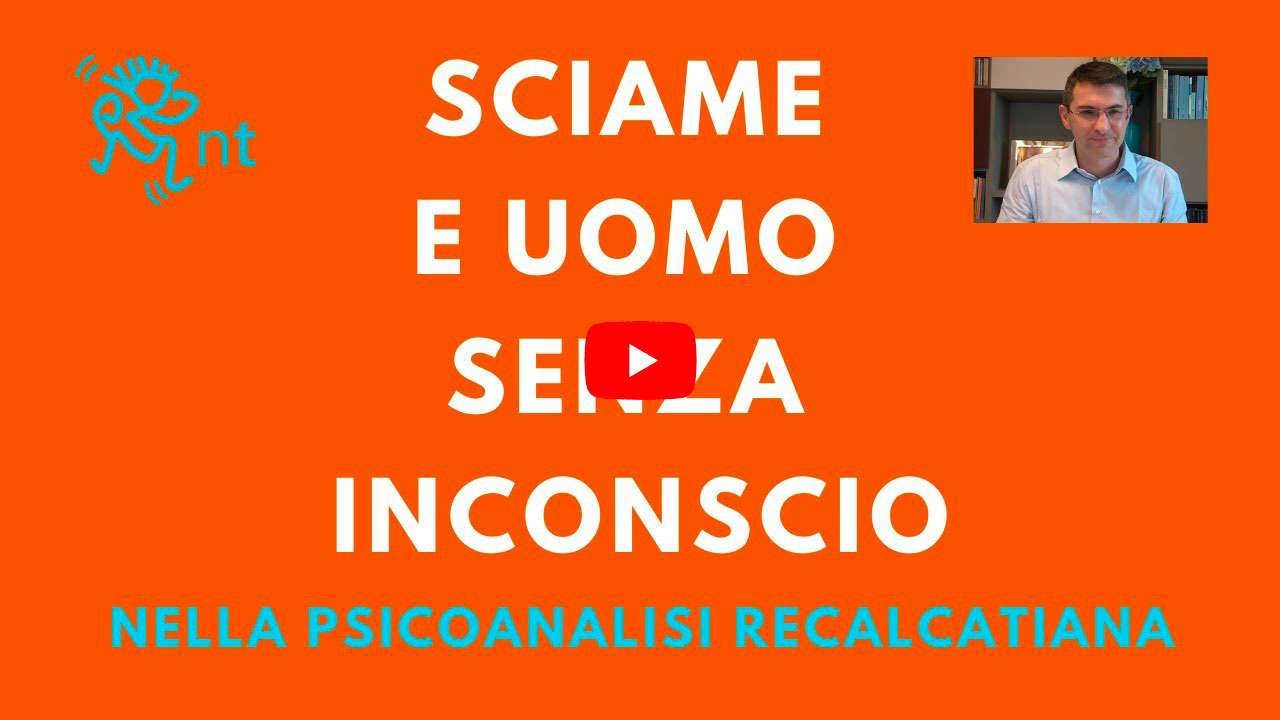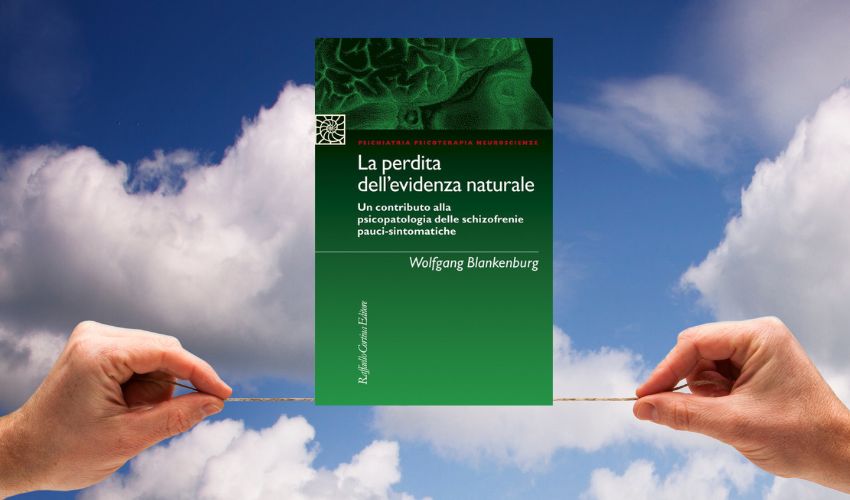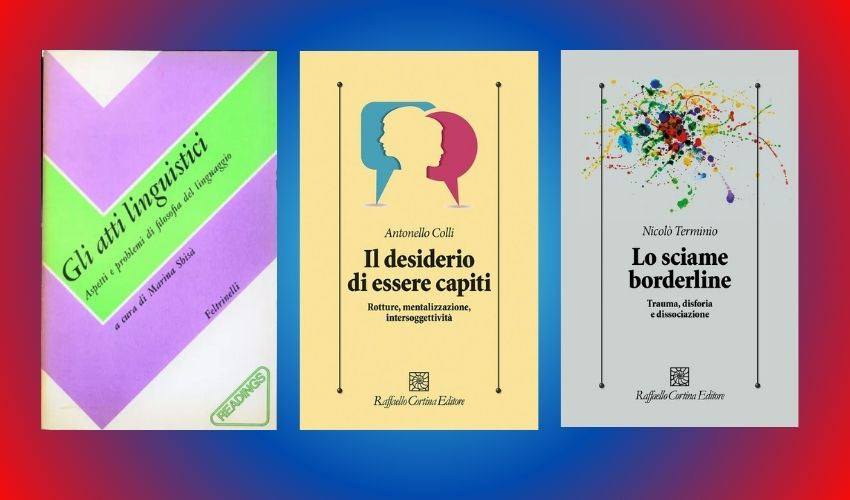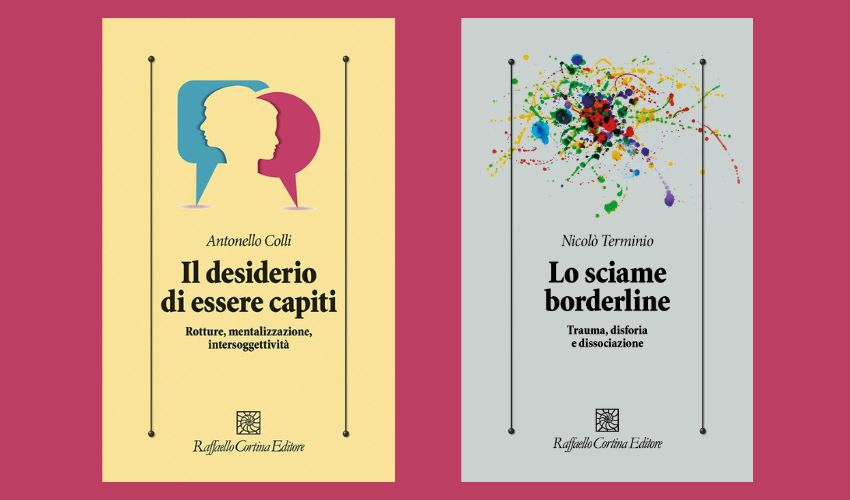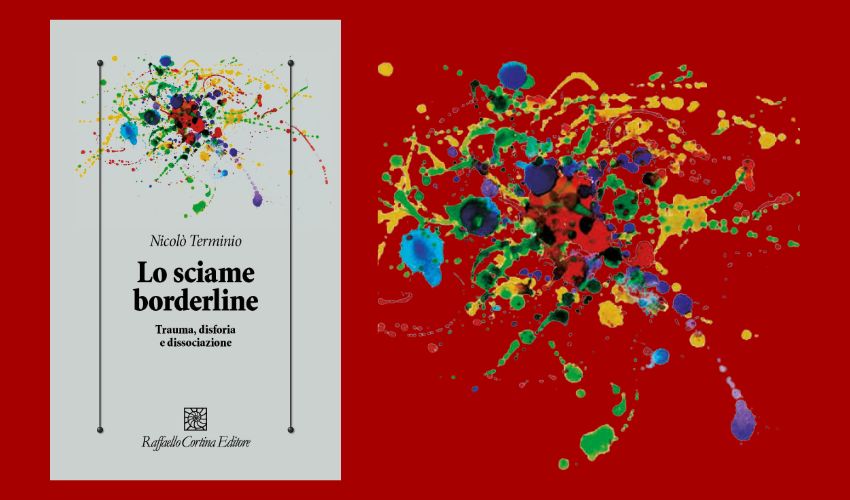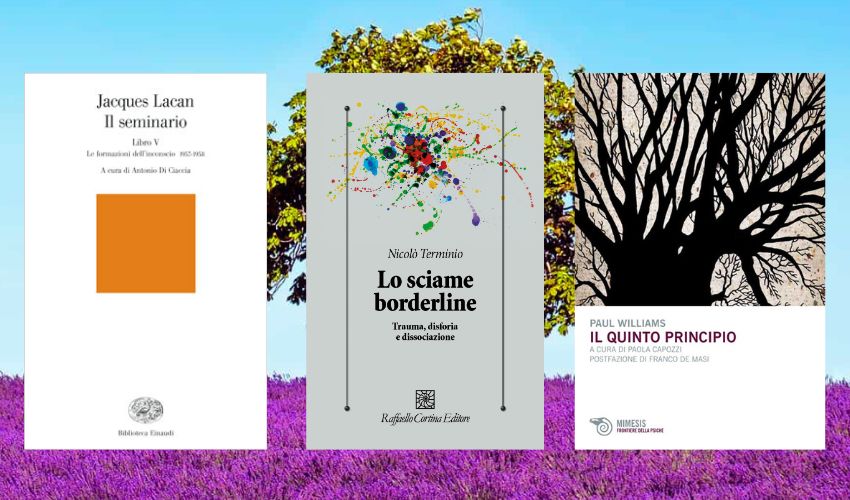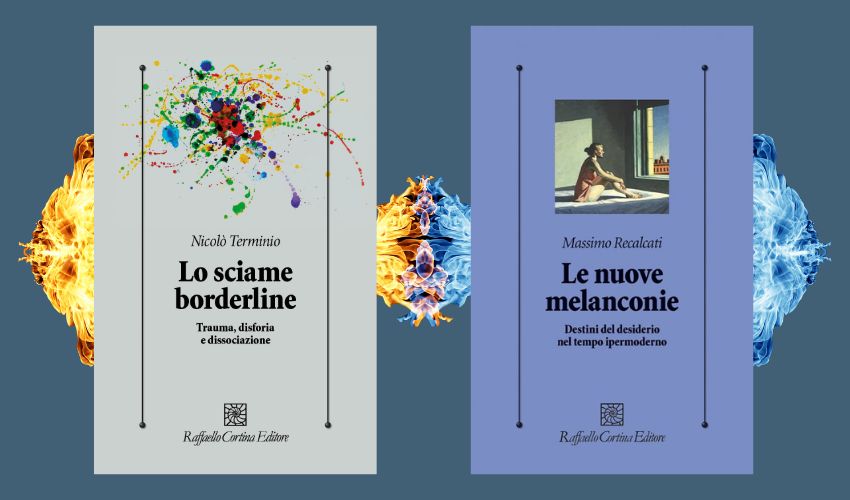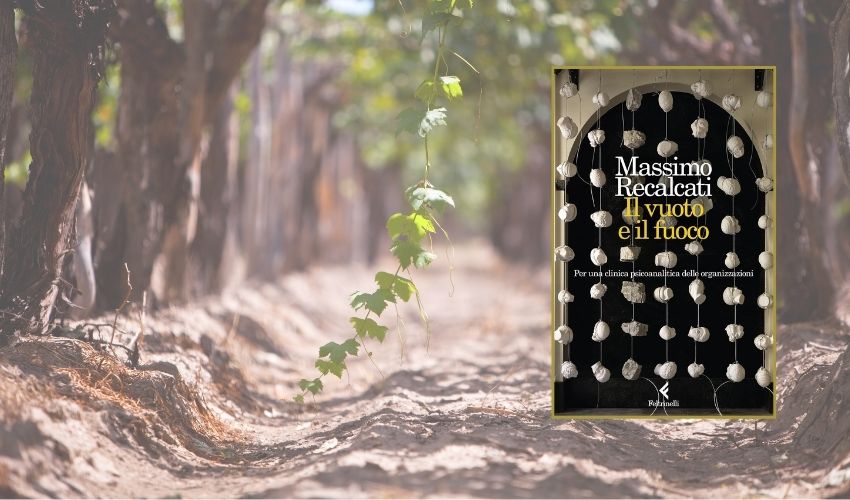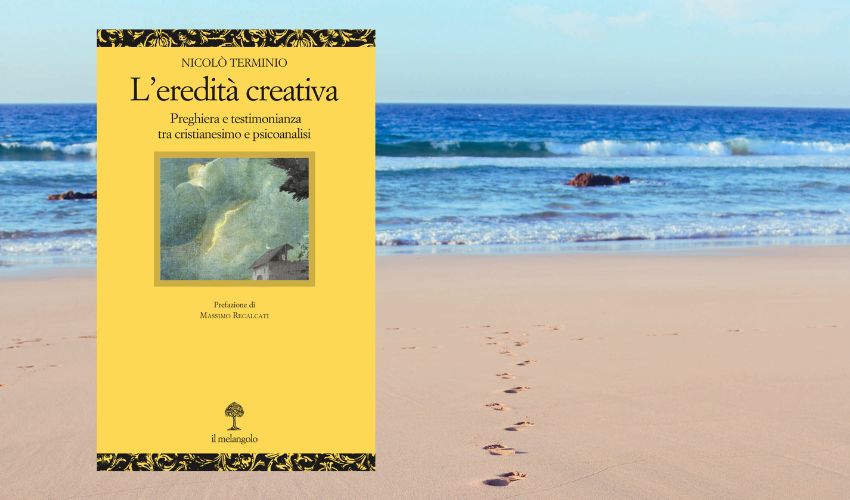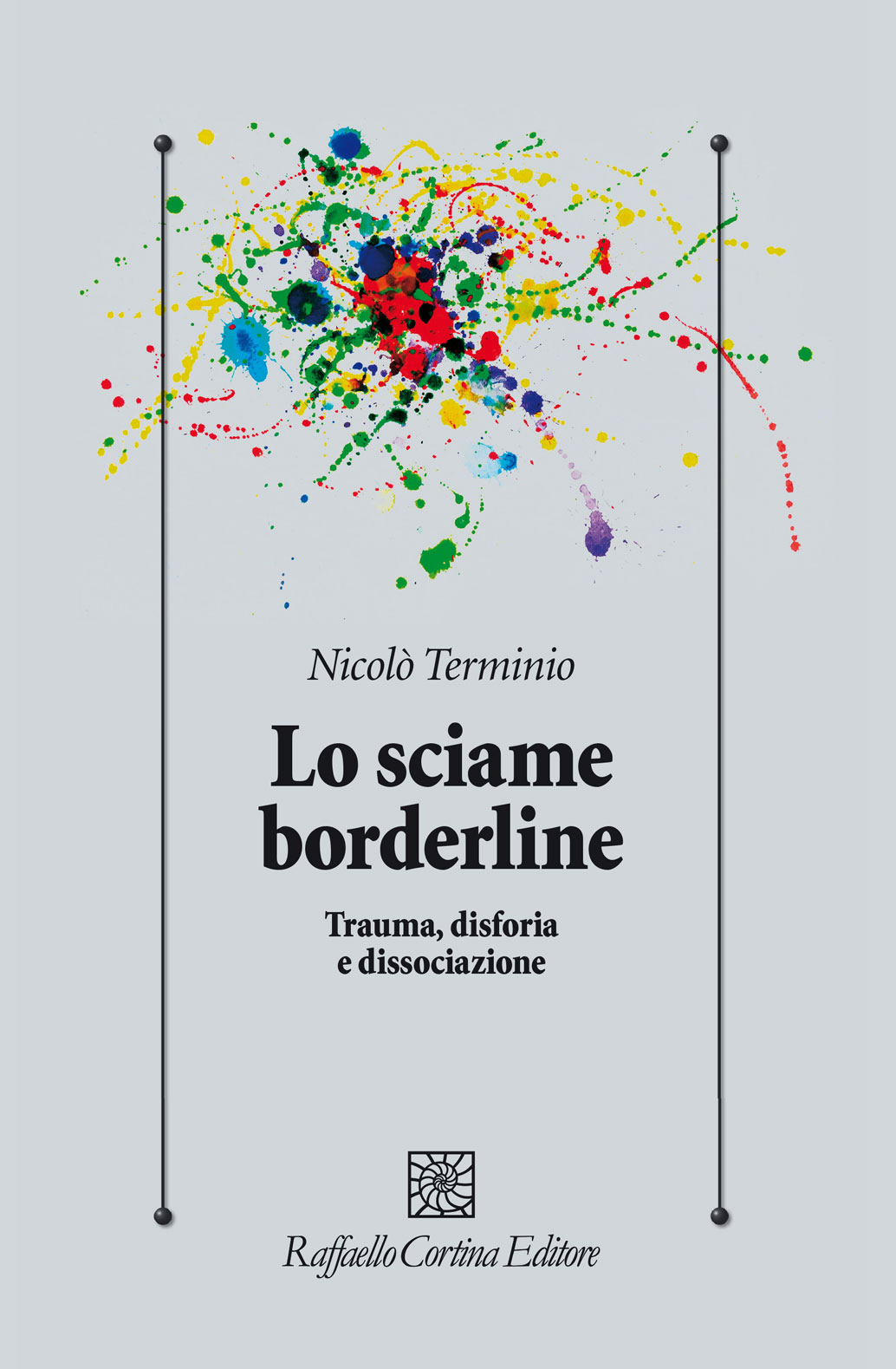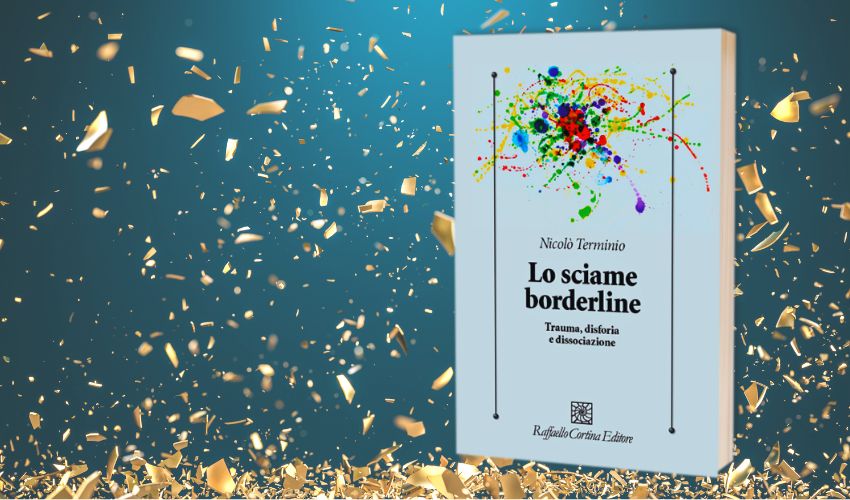
Janet e Freud: dissociazione e rimozione: sciame e struttura
Nell’esperienza traumatica ci accorgiamo tutti quanto la tensione psichica, che ci fa tenere insieme i vari aspetti della nostra vita, sia dipendente dal contesto relazionale e dalle coordinate simboliche del mondo in cui viviamo.
Ce ne siamo accorti tutti, ad esempio, durante la pandemia da Covid-19 quanto la forza di sintesi della nostra coscienza dipendesse da una serie di certezze implicite che davamo per scontate.
La capacità di sintesi e integrazione dei diversi aspetti della nostra realtà è stata messa a dura prova quando un evento, inatteso e fuori trama, ha messo in discussione i nostri abituali riferimenti simbolici e concreti.
Di fronte a un evento che si è presentato senza avviso e senza una chiara spiegazione, molti di noi sono rimasti frastornati e angosciati perché sentivano vacillare quel pavimento sotto i piedi che consideravano scontato e granitico.
Nell’esperienza traumatica la tensione psichica che tiene insieme la catena dei significanti non è sostenuta dal mondo esterno, anzi il soggetto si trova a dover affrontare da solo il compito di tenere insieme (aggregare) i diversi aspetti della sua vita.
Nel trauma la forza aggregatrice della catena significante si affievolisce notevolmente perché i riferimenti simbolici, grazie a cui il soggetto riconosceva la trama della sua vita, non ci sono più.
Per comprendere l’impatto del trauma sulla vita psichica risultano estremamente preziose tutte quelle ricerche che hanno riscoperto il contributo di Pierre Janet per lo studio della dissociazione e dei disturbi dissociativi (Craparo et. al., 2019).
Janet utilizza il termine désagrégation – che è stato tradotto in inglese come dissociation (ecco perché in italiano ci è arrivata, di seconda mano, la parola dissociazione) – per indicare la scarsa tenuta della forza mentale, la mancata sintesi da parte dell’Io dei diversi aspetti del suo funzionamento mentale (Janet, 1889, pp. 317-326).
È importante notare che l’Io di cui parla Janet non è lo stesso Io di cui parla Lacan quando rilegge l’opera di Freud. Lacan parla dell’Io come un discorso di realtà, però quando approfondisce il concetto di Io nella teoria freudiana evidenzia prevalentemente il rapporto tra il soggetto e la sua immagine riflessa allo specchio.
"La nozione dell’io trae la sua evidenza attuale da un certo prestigio dato alla coscienza in quanto essa è un’esperienza unica, individuale, irriducibile. L’intuizione dell'io conserva, in quanto centrata su un’esperienza di coscienza, un carattere ammaliante, da cui bisogna staccarsi per accedere alla nostra concezione del soggetto. Cerco di tenervi lontani dalla sua attrazione per permettervi di cogliere infine dove, per Freud, è la realtà del soggetto. Nell’inconscio, escluso dal sistema dell’io, il soggetto parla. […] La strutturazione immaginaria dell’io si compie attorno all’immagine speculare del corpo proprio, dell’immagine dell’altro” (Lacan, 1954-1955, p. 67; p. 111).
Per Lacan l’Io si riduce essenzialmente a una funzione immaginaria, cioè alla funzione che permette al soggetto di riconoscersi nell’immagine riflessa dallo specchio.
L’Io che Lacan riprende da Freud si riferisce quindi all’asse narcisistico che collega il soggetto alla sua immagine allo specchio.
Il rapporto con l’immagine allo specchio è un aspetto molto importante del funzionamento psichico, però non esaurisce ciò che Freud riconosceva come tratto peculiare dell’Io.
Secondo Freud il funzionamento dell’Io non è del tutto riconducibile alla coscienza e l’inconscio non coincide del tutto con il rimosso. Quando Freud nella Metapsicologia si dedica all’Inconscio osserva che:
"la verità è che non resta estraneo alla coscienza solo ciò che è psichicamente rimosso, ma anche una parte degli impulsi che dominano il nostro Io, e cioè gli elementi che costituiscono la più forte antitesi funzionale rispetto al rimosso". (Freud, 1915, p. 76)
Nel corso delle sue opere Freud ritornerà ancora sul rapporto tra Io, coscienza e inconscio e in Al di là del principio di piacere sottolineerà che:
"Guadagneremo in chiarezza se invece di istituire un contrasto fra la coscienza e l’inconscio contrapporremo l’uno all’altro l’Io coerente e il rimosso. È certo che una parte notevole dell’Io è anch’essa inconscia, inconscio è proprio quello che si può chiamare il nucleo dell’Io; solo una sua piccola parte può essere designata col termine 'preconscio'". (Freud, 1920, p. 205)
E inoltre, troviamo ancora un passaggio di Freud, a proposito di una parte inconscia dell’Io che non è rimossa, in un’altra delle sue opere fondamentali, L’Io e l’Es:
"Costatiamo che l’Inc non coincide col rimosso; rimane esatto asserire che ogni rimosso è inc, ma non che ogni Inc è rimosso. Anche una porzione dell’Io, una porzione Dio sa quanto importante dell’Io, può essere, e anzi indubitabilmente è inc". (Freud, 1922, pp. 480-481)
Queste osservazioni di Freud sono molto importanti perché ci permettono di considerare due aspetti cruciali per comprendere il rapporto tra sciame e struttura: non tutto l’Io è cosciente, esiste una parte dell’Io che è inconscia; non tutto l’inconscio è rimosso, esiste un “inconscio non rimosso” (Craparo, 2018).
A questo proposito troviamo utili le riflessioni di Bollas quando sottolinea che nella teoria freudiana dell’inconscio possiamo distinguere, oltre ai contenuti rimossi, anche un’istanza della mente che opera la rimozione e che è essa stessa inconscia.
Sebbene Freud non sia stato molto esplicito nel chiarire questi aspetti teorici, Bollas ritiene che Freud abbia lasciato nei suoi scritti alcune indicazioni tacite sul fatto che:
"L’agente della rimozione è ovviamente l’Io, che fa funzionare i meccanismi mentali. È l’Io a condurre il lavoro onirico, a formare i sintomi, a memorizzare durante il giorno momenti carichi di significato psichico, a organizzare tutti quanti gli aspetti della vita inconscia. L’Io ha un interesse acquisito nella percezione della realtà, nella sua organizzazione e nella sua comunicazione agli altri". (Bollas, 2009, p. 40)
Esiste dunque una parte inconscia dell’Io che istituisce i presupposti dell’Io cosciente e che fa funzionare la vita inconscia [questi aspetti possono essere ripresi attraverso gli studi fenomenologici di Husserl (1918-1926; 1908-1937) a proposito delle “sintesi passive dell’Io” e dei casi limite della coscienza].
Ora, è di questa parte inconscia dell’Io che si occupano anche gli studi di Janet. Nei suoi studi sulla dissociazione Janet si occupa infatti della parte dell’Io che produce una sintesi dei vari aspetti del funzionamento psichico.
Quando Janet parla della funzione dell’Io che svolge la sintesi e l’integrazione psichica si sta riferendo a quella parte dell’Io che istituisce la possibilità dell’Io di integrare le percezioni e di essere presente a sé stesso. È la parte dell’Io che istituisce la possibilità del soggetto di essere cosciente di sé stesso e di avere una rappresentazione del proprio stato mentale.
Questa funzione permette al soggetto di percepire e di osservare non soltanto il proprio stato mentale cosciente, ma di registrare anche la presenza di un flusso psichico inconscio che è estraneo alla coscienza.
La sintesi dell’Io di cui parla Janet è un passaggio estremamente delicato per la costituzione della soggettività umana, perché concorre a istituire le possibilità per l’integrazione degli stati di coscienza, ma anche la possibilità per entrare in risonanza con ciò che la coscienza ha rimosso nell’inconscio.
Da questo punto di vista possiamo affermare che la sintesi dell’Io produce in primo luogo l’integrazione della coscienza e in secondo luogo la divisione tra coscienza e inconscio. Ma, possiamo anche aggiungere, giusto per non trascurare l’insegnamento di Lacan, che la sintesi dell’Io costituisce il presupposto per il riconoscimento del soggetto nell’immagine riflessa dallo specchio.
E ancor di più, sempre in un’ottica lacaniana, possiamo notare che è la sintesi dell’Io che consente il passaggio da un funzionamento basato sulla logica dello sciame alla struttura dei significanti che vengono rimossi nell’inconscio.