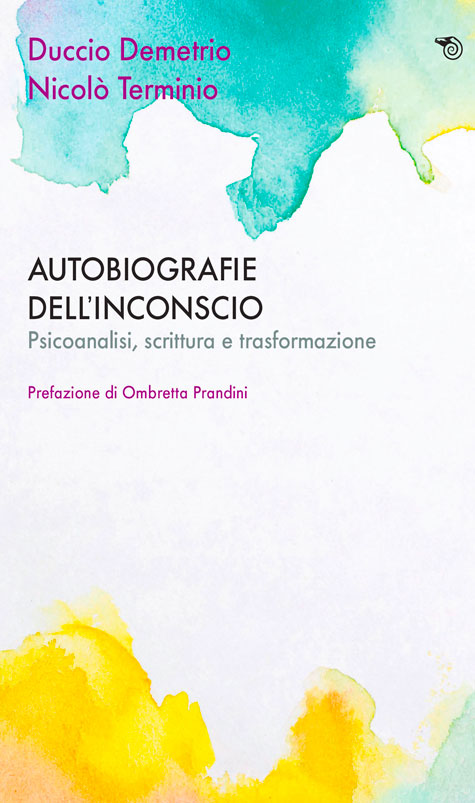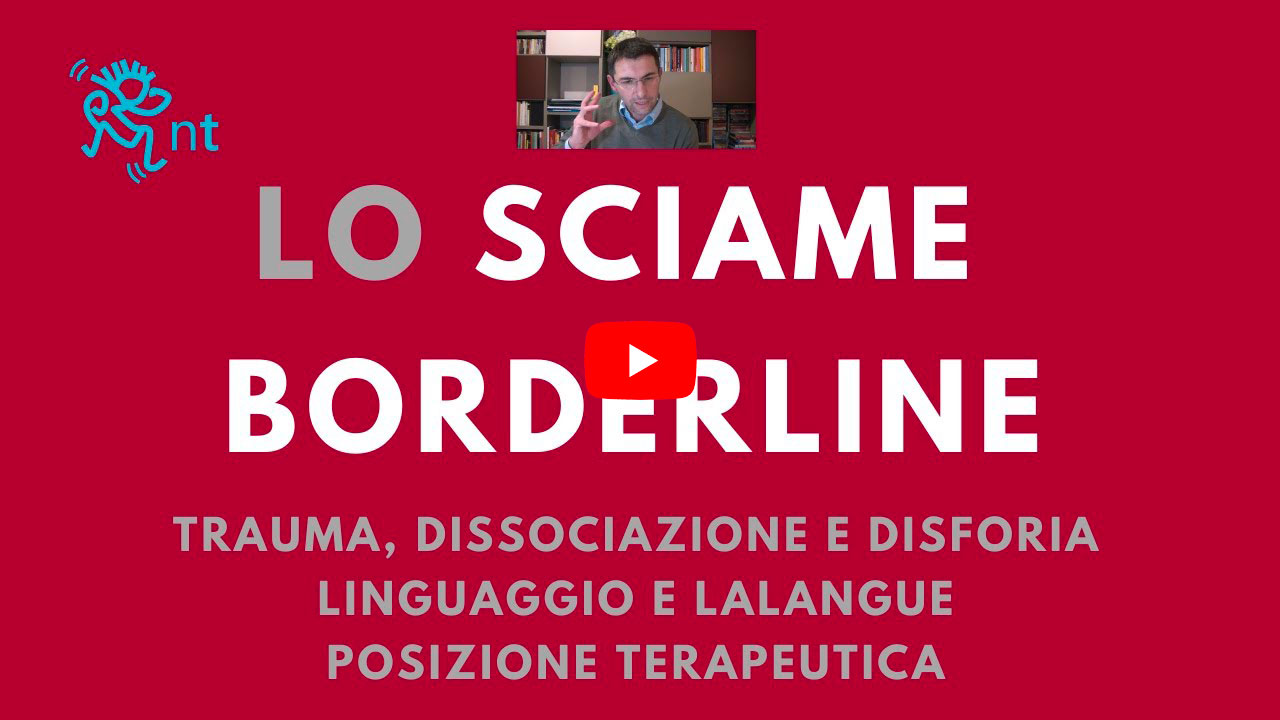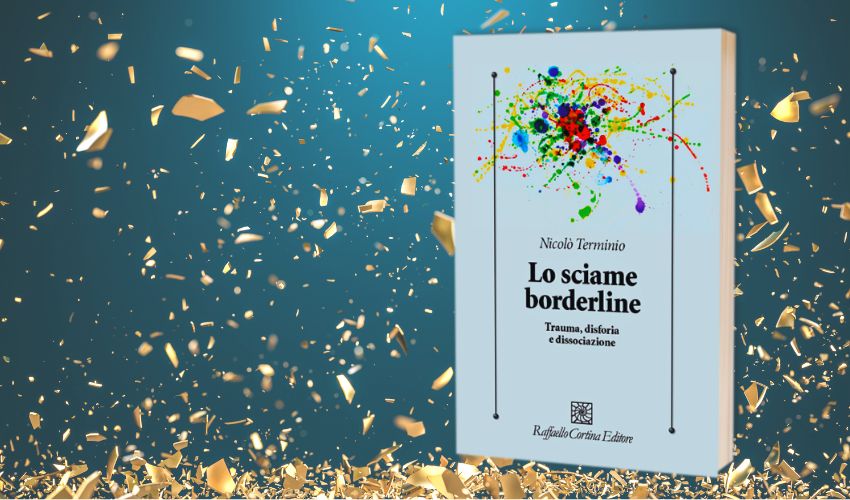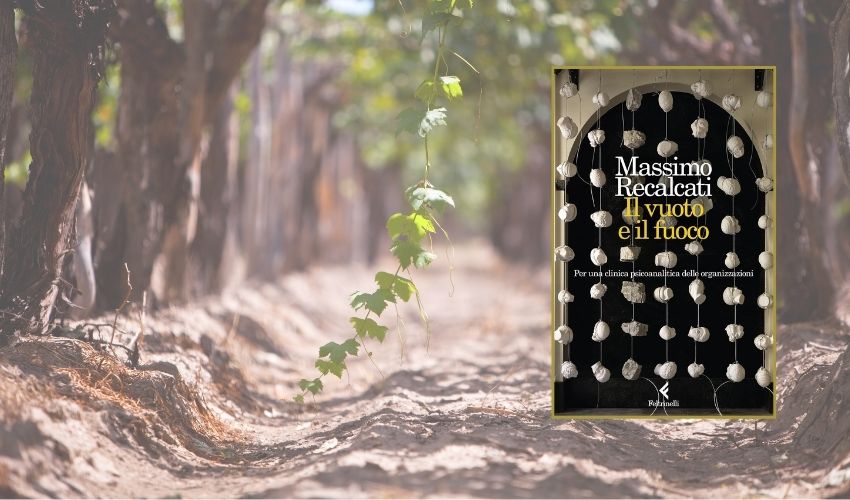Scrivere la singolarità del caso clinico
Nella scrittura del caso possiamo individuare tre livelli in cui il clinico è chiamato a compiere degli atti.
Il primo livello riguarda la pratica clinica dove è necessario che un terapeuta transiti dal sapere teorico al vivo dell’incontro. Questo primo livello riguarda essenzialmente il processo diagnostico e l’azione terapeutica, infatti la diagnosi implica un atto in cui si passa da una serie di conoscenze più o meno consolidate, secondo metodi più o meno accreditati, alla loro applicazione di fronte alla singolarità del caso clinico.
Ora, in questo transito ciascun clinico si trova ad attraversare quello iato che Wittgenstein indicava come lo iato tra le nozioni e il loro uso, osservando che non esiste una regola che ci indichi come applicare le regole. È l’assenza di un metalinguaggio che permetta di colmare quello spazio vuoto che conduce ciascun parlante dalla langue alla parole, cioè dal sistema della lingua all’atto di enunciazione.
L'atto e il Reale della pratica clinica
Quindi, già nel processo diagnostico il clinico compie un atto che è caratterizzato dall’assenza di garanzia, è un transito di cui bisogna assumersi la responsabilità senza poterla delegare ai manuali o ai protocolli già sperimentati e collaudati in altre situazioni simili a quella che si sta affrontando.
Questi aspetti diventano ancora più rilevanti nel momento in cui contempliamo l’azione terapeutica che, indipendentemente dal fatto che venga ricondotta più al piano dell’interpretazione o a quello della relazione, mostra sempre la necessità di un intervento clinico che intreccia aspetti metodologici con questioni etiche. E quando parliamo di azione terapeutica forse dobbiamo tenere in considerazione non soltanto la posizione etica del clinico, ma addirittura anche il suo stile di personalità, visto che gli studi più recenti mostrano in maniera sempre più evidente quanto la personalità del clinico sia influente per l’andamento della cura.
Nell’azione terapeutica il clinico non deve compiere soltanto un esercizio semiotico rivolto alle parole del paziente, né sostenere il paziente in questo esercizio semiotico, perché il cambiamento psicoterapeutico non consiste solo nella scoperta di un nuovo senso o nella costruzione di una narrazione più coerente e articolata.
Ciò che fa la differenza per il paziente è la possibilità di sperimentare nell’incontro con il terapeuta un’alterazione del ritmo, una variazione di quella modalità ripetitiva che rievoca quell’ombra dell’oggetto che ha impresso il suo marchio di godimento nell’essere più intimo del soggetto. E per compiere questa alterazione è necessario che il clinico si metta in gioco, prima ancora che a partire dal suo sapere, attraverso l’atto della sua enunciazione.
Enunciazione, non enunciati: non sono tanto le parole o i gesti che possono essere misurati, catalogati e valutati attraverso diverse chiavi di lettura teorica, ma l’enunciazione, cioè quella dimensione sorgiva da cui prende forma ogni enunciato. Ed è una dimensione che chiama in causa la posizione etica del clinico, non senza un riferimento ai suoi tratti di personalità. Solo se entra in atto la singolarità dell’enunciazione del clinico il paziente potrà fare esperienza di un incontro in grado di alterare e trasformare le forme di espressione della sua singolarità.
Scrivere una storia clinica
Il secondo livello dell’atto che il clinico compie nella scrittura del caso clinico riguarda il passaggio dall’esperienza alla pagina scritta. A questo livello l’atto interessa il transito dalla storia alla storiografia.
Scrivere una storia implica una marcatura del tempo, vuol dire generare un passato, circoscriverlo, organizzare il materiale eterogeneo dei fatti per costruire nel presente una ragione, un filo logico con cui organizziamo i fenomeni.
La scrittura di una storia clinica prende gli eventi e li articola e, laddove questo legame non è pensabile, cerca di ipotizzarne delle possibili forme di articolazione.
Nella scrittura del caso si tratta di far convergere la narrazione e le argomentazioni sul cambiamento e sulle scansioni della cura che lo hanno determinato.
La storiografia dei casi clinici – cioè la storia e la sua scrittura – porta nella sua stessa definizione il paradosso della messa in relazione di due termini antinomici: la realtà empirica e il discorso.
Il nostro resoconto clinico non coincide con i fatti della seduta, la selezione dei dati empirici è già un’operazione di taglio tra la realtà e il discorso.
Il discorso (della ricerca) non è la realtà (empirica) così come la fisica non è la natura.
Nella scrittura del caso clinico ci ritroviamo a compiere un atto, un passaggio non scontato e non standardizzabile che implica un gesto epistemologico che sposta la ricerca psicoanalitica verso il paradigma delle scienze storiche.
Con questo secondo taglio dobbiamo chiederci non tanto quanto la psicoanalisi sia lontana dal paradigma sperimentale, ma quanto il discorso della ricerca psicoanalitica sappia mantenere una ragione flessibile senza perdere il riferimento alla carnalità del linguaggio.
La scrittura del caso clinico vien prodotta da un taglio tra mondo e scena dove istituiamo il nostro punto di vista sul caso.
Se il primo livello dell’atto pertiene la conduzione della cura dove ci collochiamo nella posizione dell’analista e seguiamo la logica abduttiva, il secondo livello atto viene introdotto dal taglio singolare che diamo alla nostra esposizione e discussione del caso.
L’atto analitico riguarda il rapporto con il paziente, mentre il taglio con cui scriviamo il caso riguarda il passaggio dall’oralità alla scrittura e la disposizione che diamo agli argomenti per condividerli e discuterne con la nostra comunità scientifica di riferimento.
L'effetto di Reale: cura e scrittura
L’esperienza della scrittura, per lo scrittore di casi clinici, deve essere un’esperienza dell’inconscio, altrimenti è solamente un’esperienza giustificativa e non psicoanalitica.
Nella scrittura del caso clinico ci sarà qualcosa che non si potrà né dire né dimostrare sebbene siano stati seguiti alla perfezione i criteri generali della ricerca e dell’argomentazione scientifica. Questo qualcosa di non dimostrabile potrà essere soltanto mostrato con la propria voce e costituirà ciò che rende effettivamente trasmissibile una ricerca psicoanalitica.
È come se con l’effetto di Reale della scrittura dovessimo dar prova dell’effetto di Reale di una cura.
Entra in gioco non solo l’affidabilità delle argomentazioni, ma anche l’affidabilità e l’etica di chi parla. Quando un paziente diventa un soggetto singolare esce dai nostri erbari psicopatologici e mostra dei tratti individuali che non sono più l’espressione particolare di un soggetto che appartiene a un insieme generale definito dalle nostre categorie diagnostiche.
Aristotele distingueva l’universale, il particolare e il singolare: il singolare non si presenta come un caso particolare di un insieme universale, il caso singolare non è paragonabile a un altro caso.
Sperimentiamo l’effetto di Reale quando i pazienti che incontriamo, così come i pazienti di cui leggiamo le storie cliniche e le avventure terapeutiche, non sono più riconducibili ai nostri saperi precostituiti. In questi incontri iniziamo ad ascoltare i pazienti senza rivestirli con le categorie cliniche che ci sono state trasmesse nel corso della nostra formazione e che abbiamo continuato a coltivare muovendoci tra clinica e contributi di ricerca.
Rotture epistemiche
Il terzo livello dell’atto della scrittura del caso clinico riguarda l’effetto di Reale, un effetto che si produce quando il significante resiste al processo di attribuzione di significato: in questi casi ci troviamo di fronte a un paziente che fatichiamo a considerare come un personaggio raffigurato dalle nostre categorie cliniche. Semmai la singolarità del paziente diventa un’occasione per generare un personaggio letterario e in questo passaggio il paziente diventa un caso paradigmatico sebbene non vada a definire nessun nuovo modello da utilizzare come categoria clinica o esistenziale.
Deleuze, in uno dei saggi contenuti in Critica e clinica, evidenziava che i personaggi letterari sono perfettamente individuati, e non sono né vaghi né generici; ma tutti i loro tratti individuali li elevano a una visione che, come un divenire troppo potente per loro, li trasporta in un indefinito”.
Di fronte a queste storie cliniche si attiva sicuramente il processo di “simulazione incarnata”, ma a differenza di quello che avviene molto più comunemente quando ci rivediamo nei personaggi, quando arriviamo a immedesimarci e a identificarci nei personaggi, in questi casi facciamo esperienza della simulazione incarnata ma senza alcuna possibilità di identificazione con il soggetto che incontriamo sulla pagina.
In questi casi non ci riconosciamo, eppure sentiamo che parlano di Noi, di noi in quanto appartenenti al genere umano, un’appartenenza fondata non sulle identificazioni con cui ci rappresentiamo, ma a partire dai vissuti che proviamo e a cui partecipiamo.
Si tratta di una modalità di relazione che avviene non per analogia, ma per contiguità, non per sostituzione metaforica ma per prossimità metonimica, in un’apertura verso l’indefinito che è capace di generare l’assoluto, l’absoluto: ciò che è sciolto da ogni legame diventa il punto di insorgenza del legame.
E lo stesso vale anche nei riguardi del collega che ci sta raccontando il suo incontro con la singolarità del paziente. In questi frangenti il soggetto si manifesta come uno scarto singolare rispetto a tutto quanto era stato già scritto.
Ora, non si tratta di arrivare a una singolarità pura, senza le contaminazioni del sapere dell’Altro, compreso l’Altro del sapere diagnostico. Piuttosto sono dei momenti che scandiscono un cambiamento, una trasformazione che produce anche una rottura epistemica.
La singolarità del caso clinico mostra i punti di rottura epistemica delle nostre categorie attraverso l’effetto di Reale.
I momenti di rottura epistemica ci consentono di vedere che i presupposti del nostro sapere non sono granitici, ma sono il frutto e il compromesso tra varie tensioni che non riguardano solo il sapere clinico, ma anche questioni storiche, sociali e politiche.
I momenti di rottura epistemica non ci riportano alla clinica prima delle nostre categorizzazioni: non si realizza mai, come sperava il primo Foucault nella Storia della follia, la possibilità di restituire la follia a sé stessa, come se si potesse ritornare a uno stato pre-categoriale, puro e non contaminato dalle incidenze delle comunità scientifiche o dei dispositivi istituzionali. In questi momenti si scopre piuttosto che non esiste una garanzia divina per i nostri saperi. Alcuni vogliono comunque crederci e così ritengono che mettere in discussione, per esempio, il pensiero di Freud o Lacan sia una violazione del sacro, quando invece si tratta solamente di considerare che non esiste un Altro che faccia da garante assoluto, perché è illusorio pensare che ciò che connota i nostri saperi e le nostre pratiche sia detto o scritto una volta per tutte da Uno solo. Forse sarebbe tranquillizzante, ma non è così perché non esiste l’Altro dell’Altro, cioè colui che garantisce la dimensione dell’Altro, una dimensione che siamo destinati a costruire solo attraverso il nostro fare comunità.
Nei momenti di rottura epistemica ci accorgiamo che in fondo le nostre teorie sono tanti dialetti di una stessa lingua, i nostri orientamenti terapeutici sono tanti dialetti di una lingua che, va ricordato, non esiste.
Non esiste un metalinguaggio, non esiste un modello che possa riunificare le varie singolarità.
Come sostiene Bollas, ci servono più teorie perché le teorie sono delle modalità di percezione prima ancora che delle forme di concettualizzazione. E per apprendere le teorie ci vuole tempo perché per apprendere una nuova teoria bisogna entrare in una nuova modalità percettiva, occorre fare un movimento diverso dall’apprendimento di una conoscenza, bisogna trasformarsi o, come suggeriva Ghent, sapersi abbandonare. È questo il dono e il magistero che ci offre la singolarità del caso clinico.
Per qualche spunto in più guarda questo video su lo sciame, la lettera e il godimento: