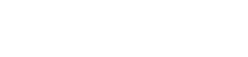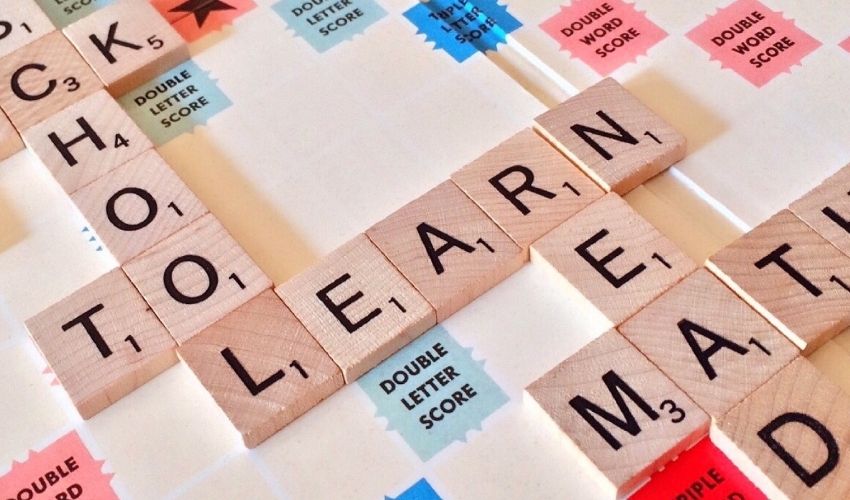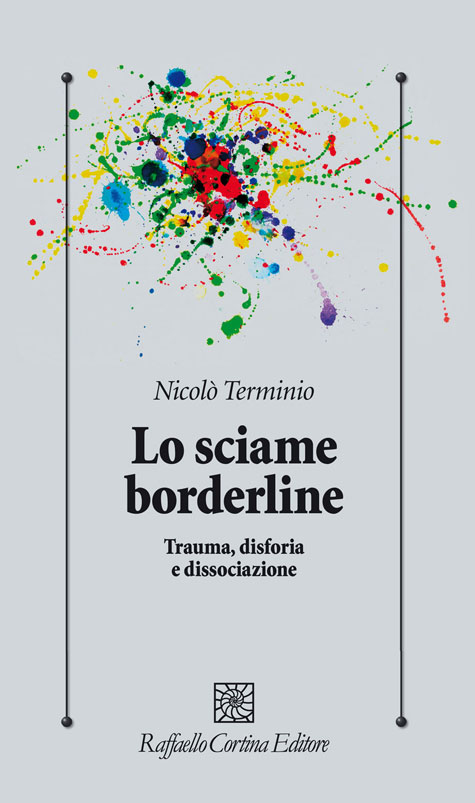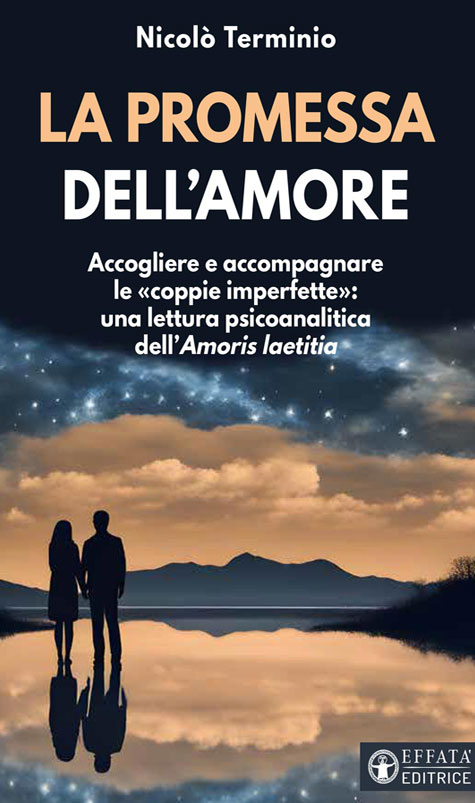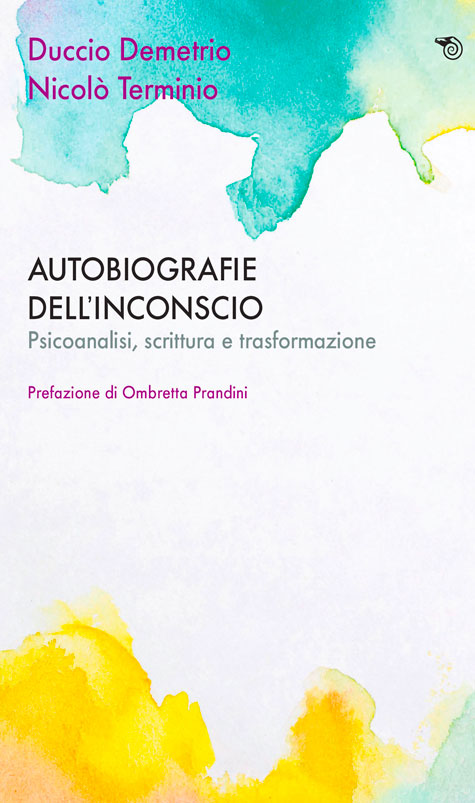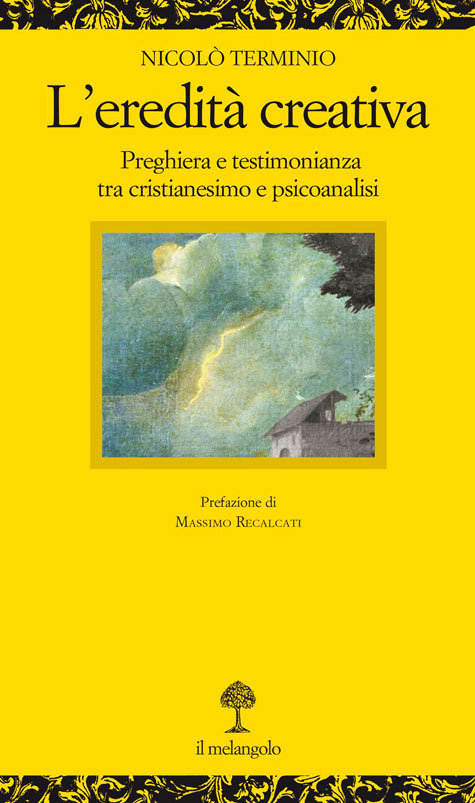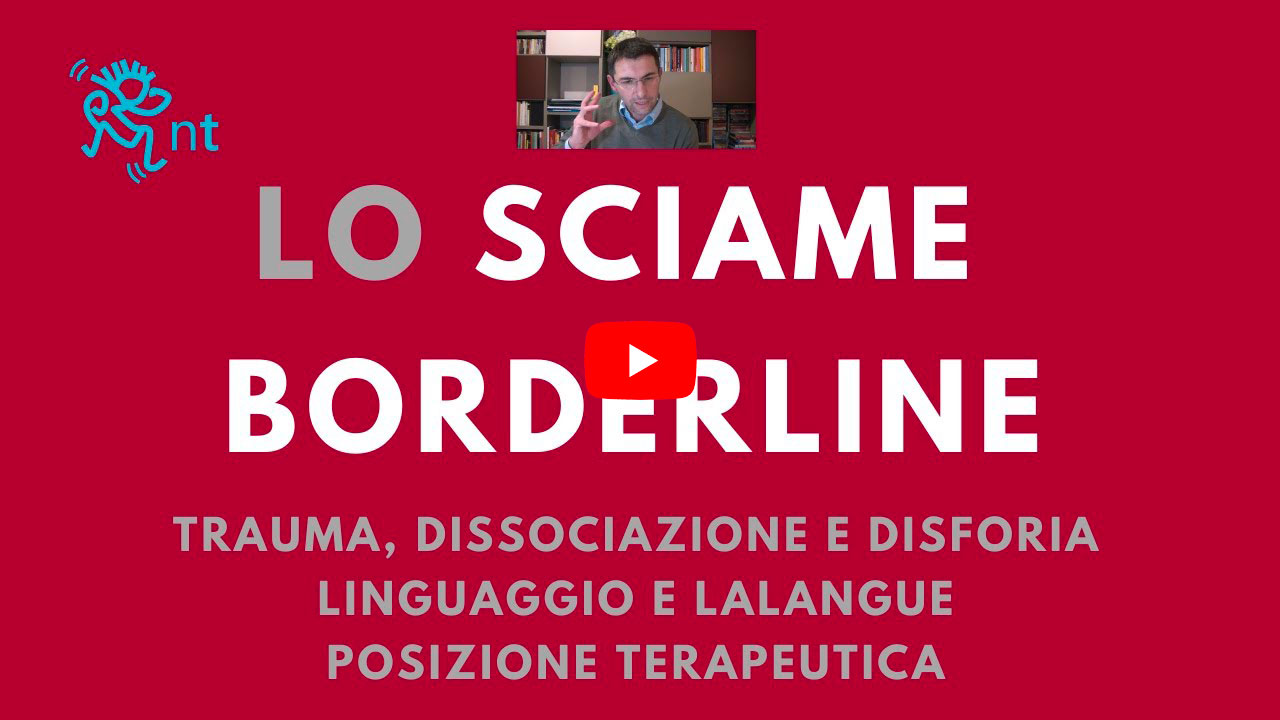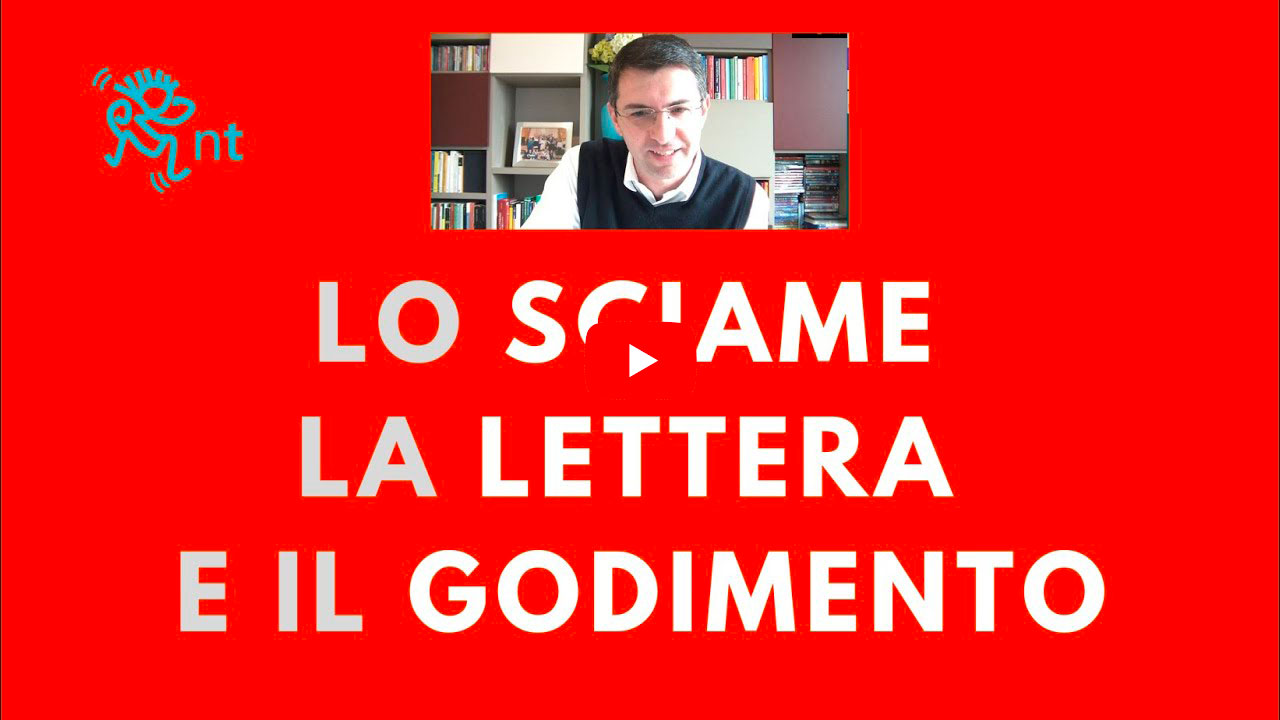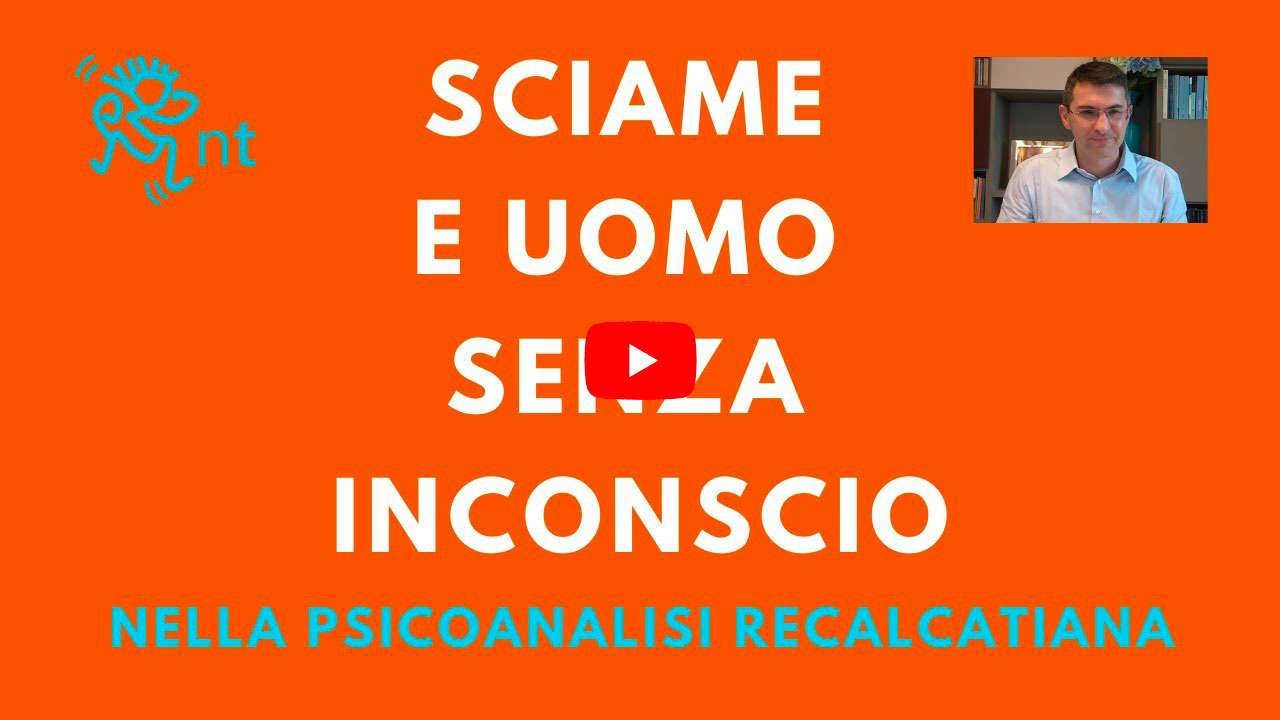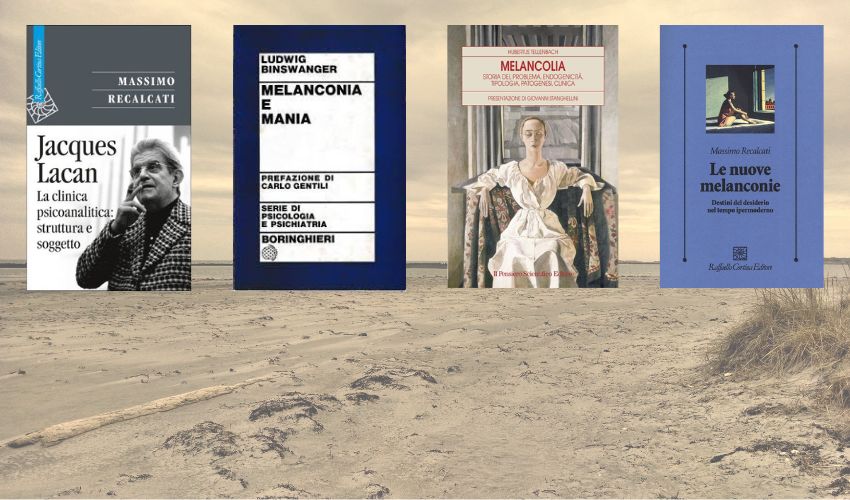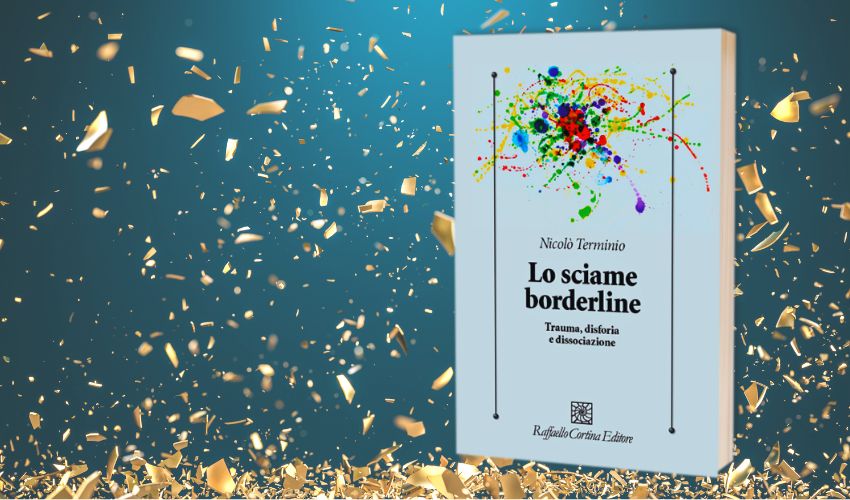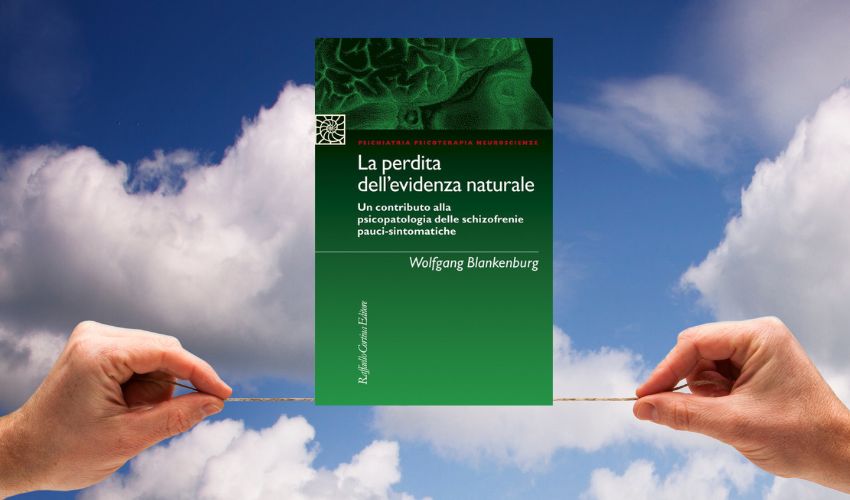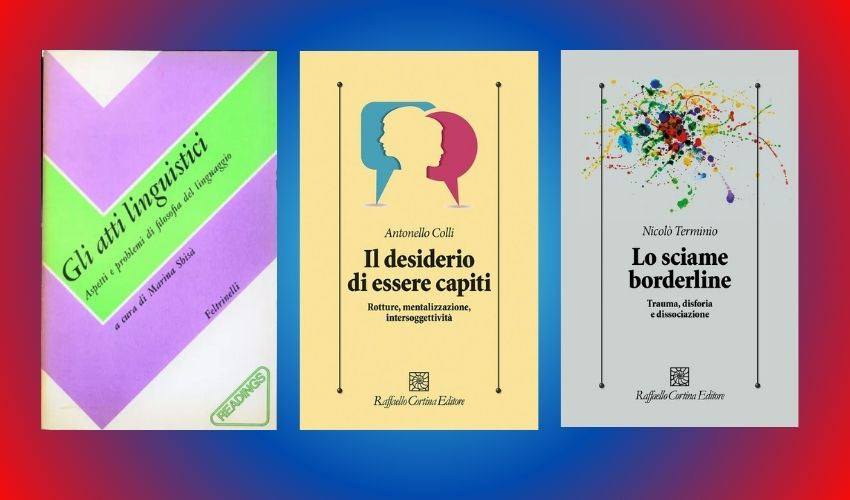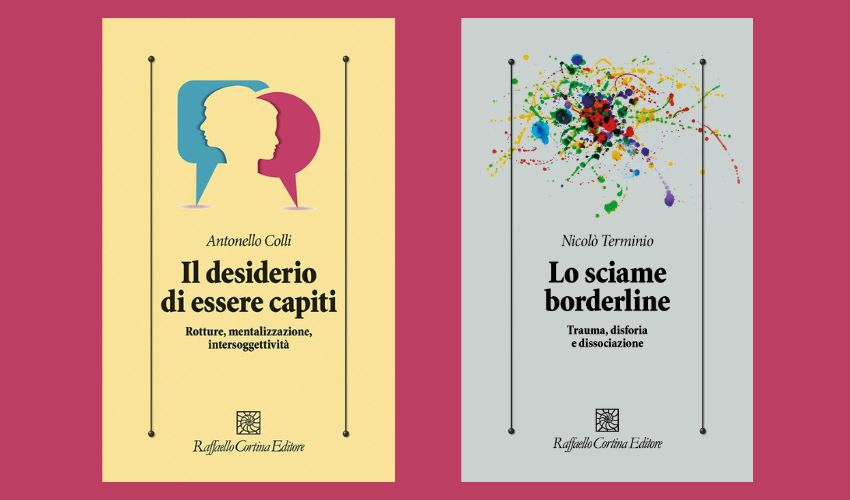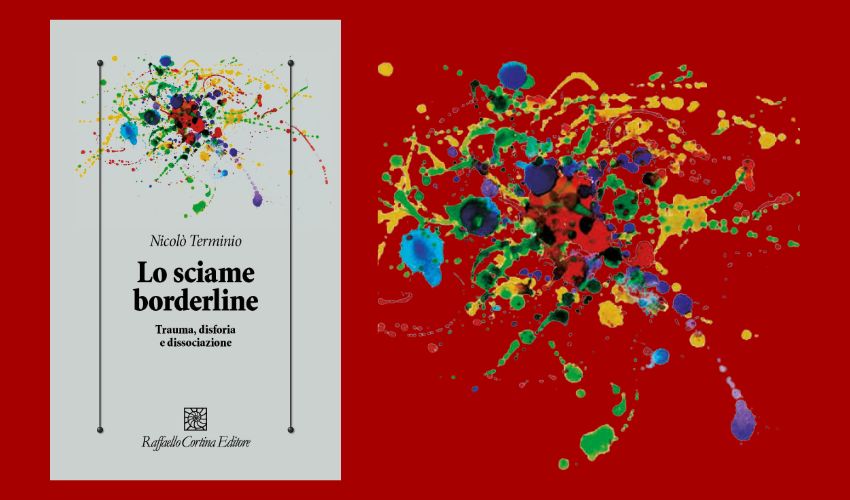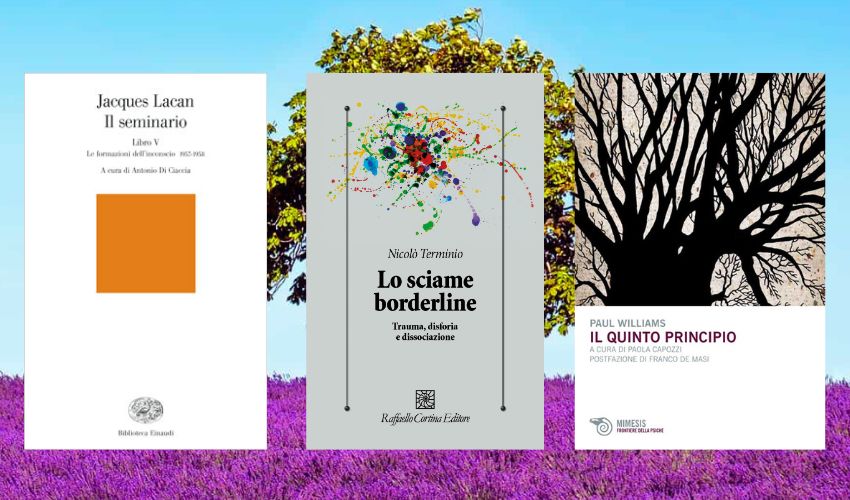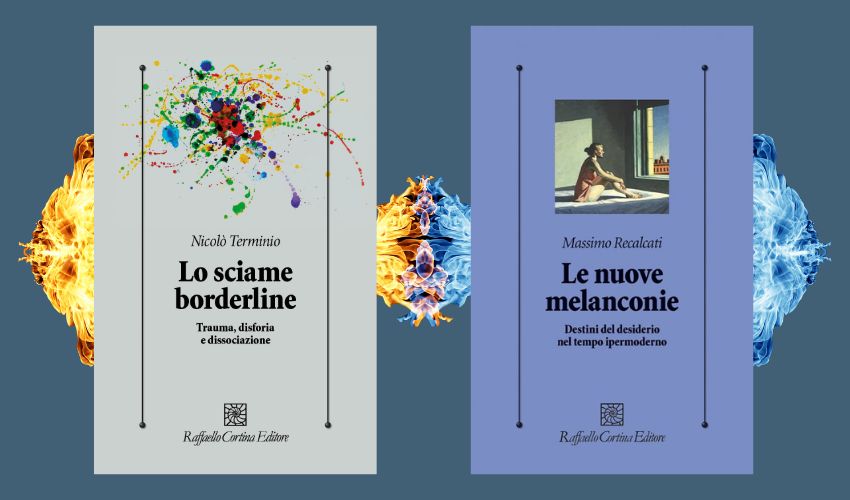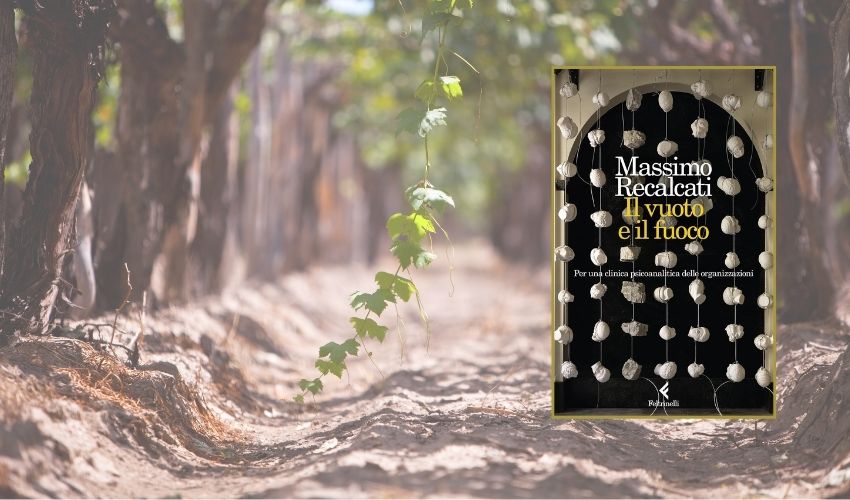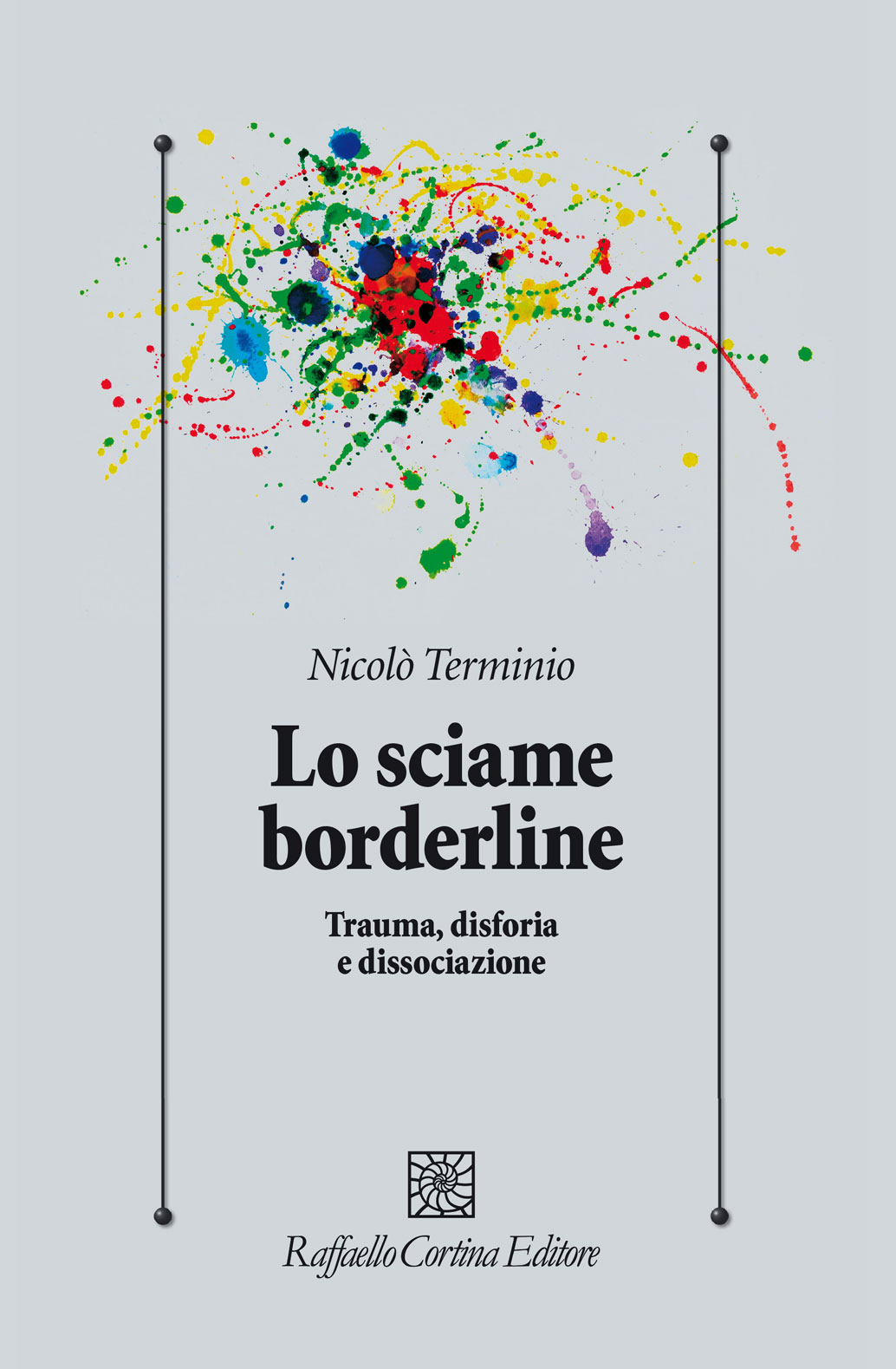Giulia Rakar è la protagonista del thriller I segni del male di Simone Regazzoni (Rizzoli 2020). Giulia Rakar è una profiler, ma anche qualcosa di più, infatti i suoi colleghi l'hanno soprannominata la "sensitiva". Nel suo approccio sembra esserci qualcosa di ultrasensibile che rispecchia una personalità complessa e una storia avvolta dal mistero.
Il compito principale della famiglia è quello di trasmettere l'apertura verso l'esperienza del desiderio. Nel rapporto tra genitori e figli il desiderio è un ingrediente fondamentale per costruire una trama intergenerazionale.
Il desiderio è una vocazione e la Legge è una sintassi che vincola la vocazione a trovare una forma. Sintassi vuol dire organizzazione di elementi che segue una successione temporale, cioè un tempo che non può essere schiacciato sull’istante.
In questo spunto presento una breve panoramica sul tema della relazione e della separazione nella costituzione del Sé attraversando il pensiero di alcuni importanti psicoanalisti del dopo Freud.
Nel suo discorso il soggetto isterico si sente escluso dal luogo dell'Altro. La posizione isterica si configura infatti come un'eccezione rispetto a ogni presa simbolica dell'Altro.
La singolarità dell'esistenza di ciascuno di noi si esprime attraverso il modo in cui viviamo il tempo. Potremmo dire che un soggetto esprime la sua singolarità in base al modo in cui il tempo vincola la sua esistenza.
Nell'ultimo insegnamento di Lacan il rapporto tra il Simbolico e il Reale viene concettualizzato attraverso la distinzione tra significante e lettera.
Le psicosi sintetiche ci permettono di comprendere la clinica della tossicomania senza cedere però alla tentazione nosografica della doppia diagnosi.
L'amore di coppia è uno dei modi per far esistere la funzione paterna nella vita familiare. Per cogliere questa possibilità è importante però accorgersi della differenza tra figura paterna e funzione paterna.
Il termine borderline sembra rivelare in modo autoevidente il suo significato psicopatologico e viene spesso utilizzato, anche al di fuori dei contesti clinici, per indicare delle persone o delle situazioni che stanno al confine e che alla fine non stanno né di qua né di là.
Nella cura psicoanalitica il transfert segna l'inizio di un viaggio alla scoperta della propria verità. E si tratta di una verità che viene ricostruita ripercorrendo la propria storia.
Le diagnosi sono storie, storie che intrecciano ripetizione e cambiamento. Esiste un aspetto stabile della struttura del soggetto, ma la struttura non dice l'ultima parola né sul destino del soggetto né sulla verità che attraversa la sua vita.
Il gioco d’azzardo patologico (GAP) è una dipendenza patologica molto grave sebbene non contempli l'abuso di sostanze.
Il GAP è molto subdolo, infatti quando guardiamo una persona non ci accorgiamo facilmente se è un giocatore d'azzardo come avverrebbe invece se fosse un alcolista o un tossicodipendente perché nelle dipendenze da sostanze psicoattive il corpo a un certo punto fa trasparire anche agli altri quella verità che si cela dietro le false apparenze.
Dietro il luccichio che contorna il gioco d'azzardo c'è uno sfondo nero che annienta ogni possibilità di ritrovare sé stessi.
I discorsi pubblicitari dei brand che accompagnano la nostra vita provano a sedurci con quelle stesse luci che sembrano prometterci una vita finalmente soddisfatta. Il consumismo va a braccetto con l'azzardo perché fa balenare la possibilità di una pienezza che in realtà non arriverà mai.
Ci sono tre stadi nel gioco d'azzardo patologico. I pazienti, quando ormai la loro vita è quasi distrutta, ci raccontano che all'inizio giocavano per vincere. A un certo punto però la loro compulsione è diventata più forte e si è sganciata persino dall'aspettativa di vincere.
In questo breve spunto propongo una rapida panoramica sulle teorie di Kohut, Kernberg, Stern, Mitchell e Lyons-Ruth. Nell’approccio teorico di questi autori la relazione con l’Altro risulta fondamentale per poter comprendere gli inciampi psicopatologici che possono compromettere la costituzione del Sé.
Il libro a sinistra è un'interessante introduzione ai processi neurocognitivi sottesi alla nostra esperienza della lettura.
L’atto della testimonianza riguarda qualcosa di intestimoniabile perché c’è quel vuoto centrale che viviamo in esilio da ogni identificazione.
Nel tempo dell’eterno presente caratteristico dei social, che ha radicalmente riformulato la nostra dimensione relazionale, sembra che occorra ripensare anche l’insegnamento.
Nel modello relazionale-simbolico sviluppato dalla scuola di Scabini e Cigoli troviamo due vertici di osservazione esplorare ogni programma di educazione sessuale che non sia semplicemente un’ortopedia del comportamento sessuale ma un’apertura sulla relazione affettiva e sessuale.
Quando si invecchia bisogna fare i conti con le identificazioni che hanno guidato l’intero percorso di una vita, bisogna lasciarle e scoprire che “la verità del mattino diventa l’errore della sera” [Jung C.G. (1930), “Gli stadi della vita”, in Opere, vol. VI, Bollati Boringhieri, Torino 1976, p. 478].
Nel suo modello dell’interazione bipersonale Joseph Sandler sostiene che nei rapporti quotidiani il comportamento di una persona possa suscitare nella mente dell’Altro particolari rappresentazioni di ruolo.
Con il termine realtà psichica (Realität) non si intende semplicemente l’oggetto di studio della psicologia, ma si sottolinea ciò che l’uomo esperisce come «una particolare forma di esistenza che non deve essere confusa con la realtà materiale (Wirklichkeit)» [ S. Freud (1899), L’interpretazione dei sogni, in Opere, vol. 3, Bollati Boringhieri, Torino 1967, p. 564].
I filosofi della mente indicano con il concetto di posizione intenzionale la facoltà di attribuire credenze, aspettative e motivazioni a sé stessi e agli altri. L’acquisizione di una teoria della mente (mentalizzazione), secondo gli psicologi dello sviluppo, avviene intorno al secondo-terzo anno di vita, richiedendo al bambino la consapevolezza di sé, la capacità di far finta (ben evidenziata nel gioco) e la capacità di distinguere la realtà materiale da quella psichica.
Continua in questo spunto la riflessione sulla costituzione del soggetto e la relazione con l’Altro. Attraverso una panoramica sul pensiero di Winnicott, Balint e Modell vediamo ribadita la centralità dell’Altro per la nascita di un soggetto capace di autenticità e desiderio.
La psicoanalisi lacaniana è una delle terapie psicodinamiche. Nella prospettiva psicoanalitica il sintomo è innanzitutto il frutto di una storia. I sintomi non sono disturbi da aggiustare o da eliminare, sono semmai degli indicatori preziosi per scoprire la dimensione più intima e soggettiva dei pazienti.
In ambito lacaniano c’è un ritornello che dice che nella clinica dei nuovi sintomi dobbiamo far passare il soggetto che chiede una cura “dalla domanda di trattamento al trattamento della domanda”.
Il tratto intellettuale di Recalcati è un movimento che va dalla teoria alla pratica, ma in un senso più ampio rispetto a quello terapeutico perché si tratta di un passaggio che va dal pensiero clinico all’impegno civile.
Sottocategorie
La pratica psicoanalitica di Nicolò è caratterizzata dal confronto costante con la ricerca scientifica più aggiornata.
Allo stesso tempo dedica una particolare attenzione alla dimensione creativa del soggetto.I suoi ambiti clinici e di ricerca riguardano la cura dei nuovi sintomi (ansia, attacchi di panico e depressione; anoressia, bulimia e obesità; gioco d’azzardo patologico e nuove dipendenze) e in particolare la clinica borderline.